
Quando apriamo l’armadio
In una famosa scena di The Devil wears Prada del 2006 Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep, dice ad un certo punto “tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito”.
Molte e molti di noi stanno in questi giorni affrontando il famoso “cambio dell’armadio” per mettere a riposo i capi invernali e portare in evidenza quelli primaverili ed estivi. Proviamo, quando apriremo l’armadio per farlo, a guardare cosa ci troviamo dentro.
Senza scomodare Marie Kondo, nel mio ci sono troppi abiti.
Alcuni non li indosso da anni, ma li tengo: per affezione a volte, a volte perché mi spiace buttare un bel capo. Camicie, maglioni, giacche, qualche abito, fatti con ottimi materiali, confezionati bene.
Poi c’è molto altro, che ho acquistato soprattutto negli ultimi anni, in eccesso, senza necessità vera, ma per il piacere di acquistare e perché spesso il costo irrisorio non mi faceva sentire in colpa.
L’estate scorsa avevo una mezz’ora di tempo prima di un impegno e per passare il tempo sono entrata nel negozio di una catena di fast fashion di un grande centro commerciale. Un negozio enorme dove erano in corso da tempo i saldi. Ho iniziato a girare guardando cosa era esposto: gli stender erano pieni di capi, talmente compressi che si faticava a guardare quanto era appeso. C’era moltissima merce in saldo, altrettanta marcata come new collection, praticamente quasi identica e dentro al negozio forse una decina di acquirenti, alcuni dei quali con bracciate di abiti con cui andavano alla cassa.
Era evidente che la maggior parte di quanto esposto sarebbe rimasto invenduto e quindi dove sarebbe finito? Non in un outlet, né in un mercatino, perché il fast fashion non utilizza questi canali.
Ed i capi che le persone si stavano portando a casa dopo l’acquisto? Spesso in materiale sintetico, dopo uno o due lavaggi non reggono e quindi vengono buttati, o peggio neanche indossati.
Ho iniziato ad interessarmi al tema e grazie anche ad una serie di articoli apparsi su La Nuova Ecologia e ad alcuni libri ho appreso diverse cose.
Come siamo arrivati al fenomeno della fast fashion?
Nell’800 nasce, in particolare in Gran Bretagna, l’industria tessile, che ha permesso di produrre tessuti in maggiori quantità ed a prezzi minori rispetto alla tessitura su telai tradizionali. Questo ha dato anche il via ad abiti prodotti in serie, destinati alla classe media, spesso cuciti in casa da persone che lavoravano per compensi molto bassi.
In realtà fino alla fine della seconda guerra mondiale la maggior parte delle donne continuava a cucirsi gli abiti in casa. Negli anni ‘50, in particolare le giovani generazioni, iniziarono ad acquistare abiti prodotti in fabbrica: H&M nasce ad esempio nel 1947. In Italia negli anni ‘60 si diffusero capillarmente i “grandi magazzini”: Upim e Standa in particolare, negozi dove si poteva acquistare anche abbigliamento a prezzi abbordabili che poteva permettersi anche la classe operaia. All’estero nascono nel 1964 Topshop in Gran Bretagna, Primark a Dublino nel 1969.
Nel 1975 apre poi in Spagna il primo negozio di Zara, il marchio che darà la spinta definitiva al concetto di fast fashion. Inizialmente proponeva copie economiche dei capi delle maison, ma dagli anni ‘80 ha creato un nuovo concetto di moda, “istantanea”: squadre di stilisti interni sfornano continuamente nuovi capi ispirandosi alle tendenze, che oggi contribuiscono a creare. I vestiti vengono rapidamente prodotti ed immessi sul mercato, superando il concetto di collezione stagionale (i capi cambiano circa ogni mese) e di magazzino. Ogni tipologia di capo è presente in ogni negozio in pochi esemplari, generando una “corsa” all’acquisto da parte della clientela: una camicia che vedo oggi, se di tendenza, non riuscirò ad acquistarla domani perchè non sarà riassortita.
E’ chiaro come questo sistema, adottato poi anche da altri marchi, possa creare una sorta di dipendenza ed urgenza nell’acquisto, al di là della reale necessità. Inoltre nella fast fashion non esiste l’outlet, i capi non venduti vengono semplicemente avviati alle discariche.

La nuova frontiera del fast fashion è l’e-commerce. La possibilità di acquistare decine di capi con un click e poterli poi rendere ha creato un ulteriore corto circuito: abbiamo visto tutti le file nei negozi alle postazioni del reso con montagne di capi restituiti, a volte persino dopo essere stati indossati una volta senza staccare il cartellino.
Ulteriore incentivo all’acquisto compulsivo è stata la diminuzione del costo dei capi: negli anni ‘50 la spesa per l’abbigliamento copriva circa il 50% di quella complessiva, nel 2009 siamo scesi al 12%, nel 2020 al 5%. Il costo basso dei capi proposti dai colossi della fast fashion ci permette assecondare la pulsione all’acquisto: spendere 30 euro per un abito da Zara invece degli oltre 1.000 di uno “firmato” cambia completamente la prospettiva, consentendo di aggiungere anche altro senza sentirci troppo in colpa.
La vetta di questo sistema è oggi probabilmente costituita dal colosso cinese Shein, che vende solo online e spedisce in tutto il mondo dalla Cina capi di abbigliamento a prezzi bassissimi.
Nonostante ciò il giro d’affari relativo al mondo “moda” è vertiginoso: il Programma Onu per l’Ambiente lo stima in 1,5 trilioni di dollari.
Ma quanti capi vengono rapidamente prodotti ed altrettanto rapidamente gettati?
L’Agenzia Europea per l’ambiente stima che da 58 milioni di tonnellate prodotte nel 2000, in venti anni si è arrivati a 109 tonnellate e prevede che saranno 145 nel 2030.
Un cittadino europeo getta in media 11 kg di abiti ogni anno, dei quali circa l’85% finisce direttamente negli inceneritori o in discarica. Gli abiti riciclabili sono quindi pochi e di questi ancora meno vengono effettivamente riutilizzati.
Produzione e smaltimento di tutta questa iperproduzione concorrono in modo importante all’inquinamento del pianeta: le Nazioni Unite stimano che il settore sia responsabile tra il 2 e l’8% delle emissioni complessive dei gas serra e che ogni anno comporti l’utilizzo di 215 trilioni di acqua dolce, pari a circa 86 milioni di piscine olimpioniche in un mondo che ha sempre più sete. Le microplastiche negli oceani derivano per il 9% dal tessile, in quanto anche con il semplice lavaggio spesso i capi sintetici le rilasciano.
L’inquinamento inizia dai filati. Le fibre sintetiche derivano per oltre il 70% dal petrolio e, come detto prima, nelle fasi di lavaggio rilasciano microplastiche. Viscosa e lyocell derivano sì da risorse naturali come cellulosa di bambù, mais e soia, la cui produzione prevede però l’utilizzo di prodotti chimici altamente tossici. La coltivazione del cotone viene effettuata spesso utilizzando pesticidi dannosi per l’ambiente e per le popolazioni e prevede l’utilizzo di molta acqua. La lana ha invece tendenzialmente un costo per gli animali, allevati in modo intensivo e tosati in molti casi in modo barbaro.
Al costo ambientale si somma poi quello sociale: per mantenere prezzi bassi c’è un generale sfruttamento della manodopera impiegata. A partire dai campi di cotone, dove vengono impiegate spesso appunto massicce quantità di pesticidi in paesi dove non esistono tutele sanitarie per i lavoratori e dove la raccolta viene spesso affidata a donne e bambini che hanno mani più piccole. Passando per le paghe irrisorie: una inchiesta di Milena Gabanelli e Marta Camilla Foglia del settembre 2023 riporta come mentre in Italia il costo medio orario della manodopera nell’industria del tessile fosse di 27 euro lordi, già in Bulgaria si scendesse a 5,4 euro, in Cuna e Vietnam a 4 e 3 dollari, in Madagascar e Myanmar a 2 dollari. Una ulteriore inchiesta trasmessa da Channel 4, citata sempre da Gabanelli, dimostrava come i lavoratori impiegati in una delle 700 fabbriche di Shein fossero costretti a turni di lavoro di 17 ore, dovendo produrre 500 capi a testa al giorno e ricevendo 4 centesimi a capo prodotto.
Quando infine gettiamo i nostri capi non più utilizzati nelle campane apposite, cosa succede?
Qualche capo viene avviato al riciclo, per riapparire nei negozi di second hand (Greenpeace stima che meno dell’1% di quanto prodotto dalle catene di fast fashion sia riutilizzato). Altri vengono avviati al riutilizzo dei filati o dei tessuti. Il resto, la massa, viene avviato o ai termovalorizzatori o alle discariche in altre parti del mondo.
Ad Accra in Ghana è attivo il mercato di Kantamaro: ogni giorno arrivano centinaia di tonnellate di capi, delle quali moltissime essendo composte da abiti non utilizzabili dalla popolazione locale (un piumino o un cappotto non sono particolarmente utili a quelle latitudini) vengono gettate. Quanto non raccolto dalla municipalità locale, meno del 30%, viene abbandonato o gettato in discariche illegali, dove spesso viene incendiato con gravissimi danni per l’ambiente e la salute delle popolazioni locali. Greenpeace ha indagato sulla provenienza di quanto arriva ad Accra ma esiste un’opacità diffusa in merito, sicuramente molte delle etichette sono di marchi della fast fashion.
Cosa possiamo fare come singoli?
- acquistare meno capi nuovi privilegiando soprattutto la qualità degli stessi
- avere cura dei capi
- evitare le fibre sintetiche e fare attenzione alle certificazioni per quelle naturali, leggere le etichette deve diventare un’abitudine come per il cibo
- fare attenzione alle politiche di reso
- privilegiare il made in Italy o Ue perchè produzione e lavorazioni sono normati
- contribuire a creare un movimento di opinione: ricordiamoci che fino a qualche decennio fa la pelliccia era un oggetto di desiderio, oggi fa orrore praticamente a chiunque
- acquistare nei negozi di second hand e scambiare gli abiti che non utilizziamo più in uno degli swap party che vengono organizzati ormai diffusamente.
Ma soprattutto, come ha suggerito Laura Brambilla di Legambiente Italia in un incontro che ho moderato di recente: acquisire maggiore consapevolezza, quando acquistiamo e quando apriamo in nostro armadio.
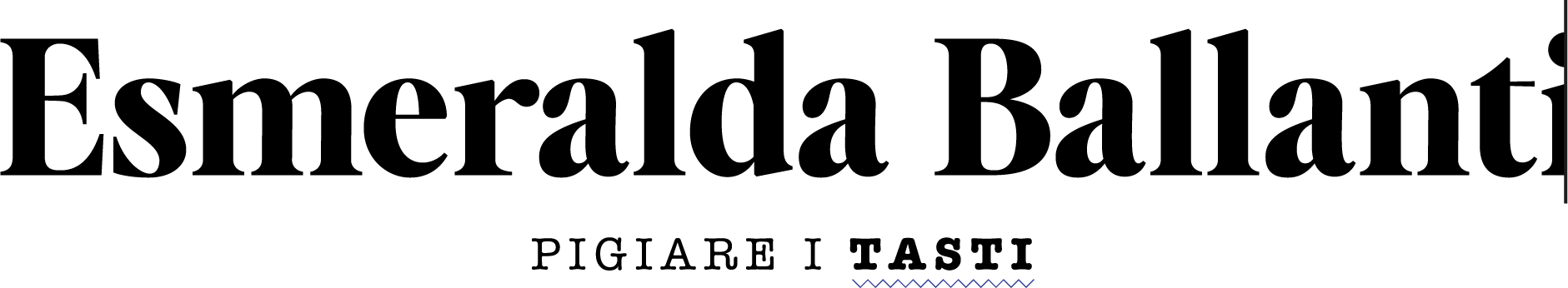





Lascia un commento